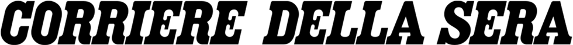Il rapporto perverso che si sviluppa tra vittima e aguzzino
di Adolfo Santoro - Sabato 18 Marzo 2023 ore 09:00

Ho esaminato la scorsa settimana la “dipendenza aggettiva” e la “co-dipendenza” come aspetti della collusione irrispettosa tra il principio maschile e il principio femminile in noi. Oggi esamino un’altra espressione di questa collusione: la “sindrome di Stoccolma”, che è il legame che può instaurarsi in un sequestro di persona tra una “vittima sensibile” e il rapitore; questo legame s’instaura quando un atto di gentilezza del rapitore riattiva nella “vittima sensibile” scene infantili di fascinazione di una figura paterna sì terrorizzante, ma improvvisamente coalizzante; ne consegue che la “vittima sensibile” percepisce la nascosta debolezza del persecutore, si rende conto che compiacendolo non sarà vittima della sua collera e diventa così complice compiaciuta.
Il nome deriva da un caso di sequestro avvenuto nel 1973, quando un uomo di 32 anni, evaso dal carcere dove era detenuto per furto, tentò una rapina alla sede di una banca di Stoccolma e prese in ostaggio tre donne e un uomo; le autorità svedesi acconsentirono alle richieste del sequestratore (la liberazione di un altro detenuto, un’automobile), ma rifiutarono di garantirgli la fuga insieme agli ostaggi. La prigionia e la convivenza forzata degli ostaggi con il rapinatore durarono oltre 130 ore, al termine delle quali, grazie ai gas lacrimogeni, i malviventi si arresero e gli ostaggi vennero rilasciati senza che fosse eseguita alcuna azione di forza. Ma succedeva che, durante la lunga prigionia, gli ostaggi temevano più la polizia che i sequestratori, che furono anzi gentili verso gli ostaggi: l’evaso diede la sua giacca di lana ad una donna per coprirsi dal freddo; un altro sequestrato mostrò riconoscenza per essere stato minacciato del rischio di essere gambizzarlo, ma non di essere ucciso; qualcuno pensava al sequestratore “come a un Dio di emergenza"; tutti concordarono che i sequestratori “avevano ridato loro la vita”. Questa gentilezza dei sequestratori, all’interno della minaccia di sopravvivenza, attivò un senso di gratitudine ed un’identificazione tra tutti quelli che si trovano “in trappola”, mentre la possibile minaccia della polizia di irrompere viene vissuta come “il nemico”.
Dalla banca dati dell’FBI statunitense risulta che circa l'8% degli ostaggi ha manifestato sintomi della sindrome di Stoccolma. Nello sviluppo della sindrome occorre, dunque, che la convivenza forzata duri qualche tempo, in modo che si sviluppino tre stadi: 1) negazione dell’evento o incredulità (la vittima può anche “svenire”), 2) speranza che presto ci sarà la liberazione, 3) delusione, fare il “bilancio” della propria vita e il rapporto “umano” col sequestratore.
Le sequele della sindrome sono quelle proprie del Disturbo post-traumatico da stress con evitamenti, senso di rabbia verso la polizia, solidarietà e raccolta di fondi per i sequestratori, flash-back ed incubi.
Un’altra variabile importante è l’età della vittima: il rapimento di bambini e giovani da parte dell’organizzazione islamica “Boko Aram” ha come conseguenza che alcuni dei rapiti sono poi disposti a diventare bombe-umane.
Orwell, in “1984”, descrive Winston, che sarà liberato dalle prigioni del Ministero solo quando i suoi aguzzini avranno raggiunto il loro ultimo scopo, cioè quello di indurlo a tradire l’amata Julia, a chiedere che torturino lei al suo posto; l’amore per il regime può così prendere il posto dell’amore per l’amato: Alzò lo sguardo verso quel volto enorme. Ci aveva messo quarant’anni per capire il sorriso che si celava dietro quei baffi neri. Che crudele, vana inettitudine! Quale volontario e ostinato esilio da quel petto amoroso! Due lacrime maleodoranti di gin gli sgocciolarono ai lati del naso. Ma tutto era a posto adesso, tutto era a posto, la lotta era finita. Era riuscito a trionfare su se stesso. Ora amava il Grande Fratello.
“Il portiere di notte”, film del 1974 scritto e diretto da Liliana Cavani, si occupa dell’attaccamento post-traumatico. L’inconscio della Cavani, lesbica, si esprime bene nel connubio tra potere e sado-masochismo, come, del resto, si espresse nei film di altri omosessuali dell’epoca: “La caduta degli dei” di Luchino Visconti del 1969 e “Salò” di Pier Paolo Pasolini del 1975.
Il portiere di notte dell'Hotel der Oper di Vienna è Max, che vi lavora grazie ad un’associazione di ex nazisti che si occupa di rigenerare l’identità dei criminali di guerra tedeschi. Siamo nel 1957: Max sta svolgendo il suo lavoro in maniera inappuntabile, pronto anche a soddisfare le esigenze più insolite degli ospiti, quando il suo sguardo incrocia quello di un’elegante donna, Lucia. I due si riconoscono: Max è stato, durante la seconda guerra mondiale, l’aguzzino di un lager ed ha scelto Lucia, pre-adolescente ebrea, come vittima di un gioco di assoggettamento erotico in cui lui la chiamava “la mia bambina”. Lucia è spaventata e attratta da Max e sceglie di rimanere a Vienna. La passione tra i due riesplode, mentre gli ex nazisti che li contornano esigono l’eliminazione di una testimone pericolosa. Per proteggerla Max lascia l'albergo e si chiude con lei nel suo appartamento, dove riprende forma il loro gioco sado-masochista. I membri dell’associazione individuano li assediano ed i due, stremati e affamati, indossano nuovamente le divise di un tempo, escono e, incamminandosi in un’alba irreale, vanno verso un ponte sul Danubio, dove li attende il “plotone d’esecuzione”.
Al di là del sado-masochismo, che rischiò di diventare un genere cinematografico, la Cavani spiegava così la motivazione a scrivere la sceneggiatura del film nel nascondimento degli aguzzini nazisti dopo il crollo del Terzo Reich: “… c’è questa componente di nazisti, di setta, di gruppo, perché sono scappati, sono stati rintanati dai preti, dalle suore, dalle scuole… dai nuovi governanti; si sono difesi, nascosti, stavano, proprio come talpe, nascosti nelle cantine, come topi… Le famiglie cristiane dell’Aquila hanno denunciato il film perché era immorale. Penso che la quotidianità è attraversata da tanti sado-masochismi delle persone… la violenza che c’è dentro a certe coppie… questa volontà di distruggere durante la guerra viene addirittura legalizzata, i nazisti sono stati puniti in pochissimi, però hanno fatto una roba pazzesca: non ci dimentichiamo che nei lager ci sono stati solo 6 milioni di ebrei, ma ci sono stati altri 5 milioni di persone… questo io dico che non è stato ancora bene affrontato…”. Sarà per questo che, non avendo fatto i conti con gli orrori della seconda guerra mondiale, ci troviamo di fronte agli orrori della terza guerra mondiale? Ed è stato così che gli eredi di Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler e Mussolini sono qui a decidere le sorti del mondo.
La Cavani, rievocando il come la sceneggiatura prese forma nella sua mente, parlava di una donna del cuneese, che ogni anno doveva tornare a Dachau, nel cui lager era stata rinchiusa. Questa stessa donna cuneese le raccontava: “La prima lezione l’ho imparata a Dachau dalle partigiane francesi, che m’hanno detto “Non ti permettere mai di aggredire nessuno se hai fame, perché la nostra prima regola è che sopravviveremo solo se abbiamo il rispetto l’uno dell’altro.”.”.
Ecco, mi sembra che le partigiane francesi avessero centrato il problema: di fronte alla minaccia alla sopravvivenza si può perdere la vita, ma non la dignità di vivere, il rispetto! Ben intonata a ciò è la colonna sonora del film, una vecchia canzone, “Wenn ich mir was wünschen dürfte”, già cantata da Marlene Dietrich:
“Non ci è stato chiesto, quando ancora non avevamo un volto
Se volessimo vivere o preferissimo di no.
Ora cammino sola in una grande città
E non so se lei mi voglia bene.
Guardo nella stanza attraverso porte e finestre,
E aspetto, e aspetto qualcosa.
Se potessi desiderare qualcosa,
Mi troverei in difficoltà,
Cosa dovrei desiderare,
Un momento bello o brutto?
Se potessi desiderare qualcosa,
Desidererei di essere un po’ felice
Perché se fossi troppo felice
Mi mancherebbe la tristezza.
Se potessi desiderare qualcosa,
Mi troverei in difficoltà,
Cosa dovrei desiderare,
Un momento bello o brutto?
Se potessi desiderare qualcosa,
Desidererei di essere un po’ felice,
Perché se fossi troppo felice
Mi mancherebbe la tristezza”
Adolfo Santoro